Che Hugh Jackman sia un attore completo ed eccezionale nel recitare, presentare, ballare e cantare, è un fatto più che noto, dimostrato in mille diverse occasioni. Non poteva, quindi, essere che lui l’interprete di Phineas Taylor Barnum, il self-made man dell’ottocento, che mutò il mondo dell’entertainment, l’imprenditore che mise in auge un nuovo tipo di show che coinvolgesse più classi sociali possibili, con un'attenzione particolare ai freak, protagonisti dei suoi spettacoli. Diretto dall’esordiente regista cinematografico Michael Gracey, The Greatest Showman è un musical che inserisce e rispecchia tutte le qualità possibili di chi ha lavorato al film.
A partire proprio da Gracey e da Jackman. La carriera e la vita di Barnum si è sempre distinta per il suo ottimismo verso il futuro e la conoscenza delle proprie capacità: ha saputo sfruttare a proprio favore la questione mediatica che lo ha travolto per aver convinto i freaks a lavorare per lui. Barnum non si è mai abbattuto e ha sempre cercato di creare aspettative positive per sé e per gli altri, tra cui dare ai cosiddetti “fenomeni da baraccone” una chance di farsi accettare per quello che sono e di dare la possibilità al pubblico di poterli apprezzare e di uscire dallo spettacolo più contenti di come vi sono entrati.
Gracey, regista di spot pubblicitari, non ha mai avuto il fine di creare un film che fosse un insieme di musiche riadattate alla Moulin Rouge!. Sicuramente il film si appoggia a basi Luhrmanniane, con un intrattenimento pop e legato in parte alla stessa costruzione visiva del film del 2001: entrambi seguono un protagonista che, macchina da scrivere alla mano, mette tutto se stesso nella realizzazione dei propri obiettivi, che esplode di gioia come del proprio opposto, in un connubio omogeneo tra la parte cantata e recitata. Energia, coreografie e colori che rendono questi due film quasi inscindibili e allo stesso tempo differenti.
Se Moulin Rouge! si basa una vicenda bohémienne, con una continua ascesa al drammatico e con una conclusione abbastanza rara nei musical, The Greatest Showman, pur reggendosi su una sceneggiatura (di Jenny Bicks e Bill Condon) traballante ed abbastanza ricca di imperfezioni che rischiano di cadere nel ridicolo e nel melenso, riesce ad incanalare un’energia contagiosa che persiste dall’inizio alla fine. Uno show che deve continuare per affermare le proprie qualità.
Temi come quelli dell’accettazione del diverso per classe, colori, deformità, della rivalsa e del vivere bene e in pace con se stessi, per quanto importanti, vengono solo trattati superficialmente, facendo emergere un limite di analisi; sono temi che diventano solo dei pretesti per montare un grande spettacolo (sia del film, che di Barnum). È chiaro che le parti più importanti del film sono i numeri musicali, che rendono contemporanei i temi appena detti poco sopra e che risucchiano il fruitore, con una colonna sonora di John Debney e canzoni scritte da Benj Pasek e Justin Paul (autori delle canzoni di La La Land).
Con un film del genere si può e si deve parlare di fruitore: egli non sta semplicemente guardando, ma diventa parte fondamentale della realizzazione dello spettacolo, una parte quasi attiva di questo meta-show che potrebbe trovarsi, da un momento all’altro, sospeso a mezz’aria sopra un trapezio come lo si è stati, alla stessa maniera, su quell’elefante bohémien di diversi anni fa.
Dal canto suo, The Greatest Showman riporta in auge una parte fondamentale di quel musical precedente il tramonto di fine anni ’50. Il riferimento è alla danza Kelliana: sebbene gli stili siano totalmente differenti, in questo film vi è un deciso ritorno alla danza atletica, aggraziata e allo stesso tempo così scomposta e così comunicativa che non si vedeva da tanto, troppo tempo. E questa mediazione non poteva essere, in primis, che di Jackman. Con un personaggio imbastito, cucito e ricamato sartorialmente addosso, Jackman ha dato sfogo in toto alle sue molteplici ed eccelse capacità, dimostrando ancora una volta, e una volta per tutte, che, in realtà, è lui il greatest showman. Un leader, lui così come il personaggio, in grado di innalzare ai suoi livelli un cast fatto sia di iniziati al musical (vedi Michelle Williams) sia di attori avviati (vedi Keala Settle, alias la donna barbuta) e che riesce a far sbocciare uno Zac Efron sempre relegato, suo malgrado, a ruoli teen.
Citando una celebre canzone di Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un amore verso un genere che risorge sempre dalle proprie ceneri e che, finché avrà con sé autori ed interpreti in grado di amarlo, glorificarlo, aggiornarlo e farlo amare a loro volta, non morirà mai. E non importa se il film sia perfetto a 360°: in fondo nemmeno Cantando sotto la pioggia lo è.
Recensione completa su I-FilmsOnline.
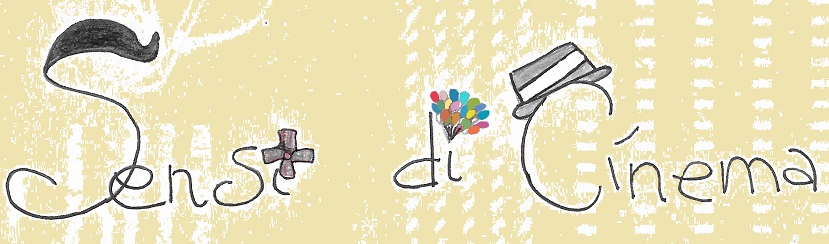



Nessun commento:
Posta un commento